Approfondimenti
I Temi
Titolo sezione

La Mostra del Barocco piemontese, inaugurata a Torino nel giugno del 1937, compare tra gli episodi che hanno segnato la cultura storico artistica ed espositiva, non solo torinese, nel corso del Novecento. La sua considerevole fortuna deriva dalla capacità di restituire concettualmente e visivamente una stagione culturale e figurativa per molti aspetti misconosciuta, oggetto di studi vecchi e nuovi, ricerche, documentazione e finalmente avviata verso un progressivo assestamento storico-critico entro un orizzonte internazionale.
Ideatore e curatore della mostra, Vittorio Viale fu dal 1930 e per oltre trent’anni direttore dei Musei Civici di Torino (Studi di storia dell’arte in onore di Vittorio Viale 1967; Pagella 2002). Qui per la prima volta le sue doti di rigore disciplinare, aggiornamento museografico e vocazione alla divulgazione confluirono in un evento espositivo di così vasta scala. La mostra (che inizialmente doveva essere su Juvarra e poi sul “Bel Settecento”) alla fine del ’36 prese forma come mostra sul Sei e Settecento, trasversale ai generi e alle tipologie, fondendo pittura, scultura, architettura e arti minori. Questa scelta consentiva di fissare lo stato dell’arte barocca in Piemonte, ancorandola a un concetto di “stile” che si alimentava delle più recenti acquisizioni storico critiche.
Accanto alla questione disciplinare, la mostra rispondeva a una specifica propensione di Viale, che sapeva tradurre gli studi in operazioni culturali e le fonti della storia dell’arte in strumenti di apprendimento. Il tema della divulgazione artistica, discusso al Congresso di Basilea del 1936 (De Logu 1936), fu per lui centrale, con i musei della città riallestiti, l’organizzazione di mostre pionieristiche e la creazione per i Musei Civici di una biblioteca specialistica e di un archivio fotografico che fu il primo nel suo genere (Viale 1933). Provengono da questo archivio le circa 1400 immagini, per lo più ricavate dai negativi su lastra di vetro, risalenti alla campagna fotografica commissionata dal direttore tra il ’36 e il ’37 per censire le testimonianze barocche presenti in Piemonte: insieme ai documenti d’archivio, questa è stata la principale risorsa utilizzata per ricostruire l’itinerario espositivo della mostra, mancando il catalogo che non fu mai pubblicato.
Il tentativo di mettere in luce (e in parte riabilitare) una stagione ancora poco compresa della storia dell’arte italiana caratterizzò una serie di mostre che si tennero a partire dagli anni Venti. Alcune furono impostate secondo un orizzonte nazionale ed offrirono a Torino l’opportunità di un primo posizionamento. La prima in ordine di tempo fu la Mostra della pittura italiana del Sei e Settecento di Firenze, organizzata da Ugo Ojetti a Palazzo Pitti nel 1922, a cui il Piemonte partecipò con opere selezionate da Alessandro Baudi di Vesme, Lorenzo Rovere e Lionello Venturi. L’esposizione seguiva infatti un criterio basato sulle “varietà regionali”, rimarcando la ricchezza e la complessità di questa stagione artistica, e il suo impatto fu tale da modificare, come ci ha ricordato Francis Haskell, «la percezione che il pubblico aveva della storia dell’arte europea» (Haskell 2001).
A distanza di pochi anni, la mostra Il Settecento italiano (Venezia 1929) usciva dal perimetro della pittura ed estendeva la visuale alle diverse arti, declinando su un arco tipologico estremamente ampio il carattere culturale ed estetico di un secolo. Qui per la prima volta il “Barocco piemontese” era inteso nella totalità della sua espressione, dalla pittura agli arredi, all’architettura. Grazie alla presenza di Midana, Rovere e Telluccini nel comitato per la sezione dei mobili, emerse in particolare la specificità della cultura d’arredo. L’impianto generale della rassegna veneziana fu analizzato meticolosamente da Viale, che impostò il progetto torinese su un’attenta compenetrazione tra generi e contesti: «La Mostra vorrebbe essere totalitaria e tutte le singolari manifestazioni del barocco dal 1620 circa alla fine del ’700, vi saranno illustrate: dall’architettura, all’urbanistica ed alla scenografia, dalla pittura e scultura al mobilio, all’arazzeria ed a tutte le minori arti: stoffe e ricami; ceramiche, argenterie, ferri, bronzi, medaglie e monete, libri ed illustrazioni del libro, incisioni, disegni, ninnoli vari» (dattiloscritto s.d., AMCTo, SMO 15.1).
Ulteriori esempi con cui Viale poté misurarsi furono la Mostra di Roma secentesca del 1930, la Mostra del Settecento bolognese del 1935 e la Mostra della pittura a Brescia del 1935. A differenza di altri casi, dove la portata delle esposizioni era propedeutica alla creazione di un nuovo museo (le collezioni comunali d’arte nel caso di Bologna, il Museo del ’700 veneziano a Ca’ Rezzonico per Venezia, entrambi inaugurati nel 1936), a Torino il processo fu inverso, interpretando invece la mostra come opportunità per ridefinire il valore storico-critico delle collezioni museali e indirizzarne le successive direzioni di crescita.
La visuale ampia che alimentò la costruzione del progetto espositivo era frutto di una salda rete di rapporti dentro le istituzioni e sul territorio. Viale aveva riunito attorno a sé gli studiosi che negli ultimi decenni avevano impostato su base filologica e storiografica una ricomposizione dell’età barocca in Piemonte: figure come Eugenio Olivero, Cesare Bertea, Augusto Telluccini, Giovanni Chevalley e Arturo Midana erano impegnate da tempo nello studio della cultura figurativa e decorativa del Sei e Settecento, oggetto di pubblicazioni e allestimenti museali ed evocata nel restauro di palazzi e residenze, tra ripristino e riproposizione in stile.
La rete di referenti di Viale si estendeva anche oltre confine, per personale consuetudine, radicata negli anni della formazione, e per tramite del suo predecessore Lorenzo Rovere, stimato erudito che teneva contatti epistolari con tutta Europa. La biblioteca dei Musei Civici conserva i cataloghi, da Rovere fittamente appuntati, delle principali mostre europee degli anni ’30, come quelle che si svolgevano in Austria e in Germania, mediate dalla figura di Hermann Voss (1884-1969). La geografia della produzione artistica italiana del Sei-Settecento, su cui si rafforzavano alcune importanti collezioni private tedesche e che si riproponeva nelle rassegne espositive (come ad esempio Ausstellung italienische Barockmalerei curata da Wilhelm Suida in collaborazione con Hermann Voss, Giuseppe De Logu e Ludwig Von Baldass presso la Galerie Sanct Lucas di Vienna nel 1937), ancora non attribuiva alla pittura piemontese una peculiare fisionomia.
Di un diverso riconoscimento godeva invece l’architettura subalpina, soprattutto grazie all’uscita nel 1931 del Theatrum Novum Pedemontii di Albert Erich Brinckmann, che ne sanciva il valore europeo e l’influenza sui paesi nordici, oltre a restituirne una sorta di catalogo su scala territoriale. Il primato dell’architettura e il suo ruolo trainante per lo sviluppo delle arti nel regno sabaudo si delineò con chiarezza nella monografia su Filippo Juvarra pubblicata da Brinckmann, Rovere e Viale nel 1937. Intorno alla figura dell’architetto messinese e alle sue imprese decorative prendeva così forma l’ossatura della mostra di Torino, ma non solo: «L’identità forte di Juvarra, che a Palazzo Madama era addirittura presente con i volumi dei suoi disegni, era sentita da Viale come colonna portante per affiancare alla ricchezza delle collezioni d’arte antica la parte riservata al Barocco, lo stile prediletto come immagine della capitale» (Griseri 1996, p. 4), con un impatto duraturo sulle scelte espositive e sulle strategie di acquisizione per il museo.
La Mostra del Barocco piemontese del 1937 era incardinata su più sedi, una più propriamente espositiva (Palazzo Carignano), le altre presentate come testimonianza storico artistica nel loro complesso (Palazzo Madama e la Palazzina di caccia di Stupinigi). Le revisioni e i nuovi allestimenti a cui erano state sottoposte negli anni precedenti le rendevano pronte per essere inserite, fisicamente e concettualmente, all’interno di una mostra che restituisse la dimensione della produzione artistica del Sei e Settecento nello stato sabaudo e si presentasse aggiornata sotto il profilo museografico.
Con il coinvolgimento delle residenze Viale offriva uno spazio significativo al tema architettonico; al contempo poteva introdurre materialmente il visitatore in contesti immersivi e resi stilisticamente coerenti, testimoni diretti di un concetto di unità delle arti su cui era impostata la sua visione del Barocco piemontese, fissata nella mostra del 1937 e maturata ulteriormente per giungere ancora più rafforzata alla mostra del 1963.
La Palazzina di caccia di Stupinigi, passata nel 1919 al demanio dello Stato, nel 1926 era stata inaugurata quale sede del “Museo dell’ammobiliamento”. Realizzato con alterne vicende sotto la guida di Augusto Telluccini, il museo riuniva alcuni dei migliori esemplari del Settecento sabaudo, nella cornice di un apparato architettonico e decorativo in cui celebrare lo sperimentalismo di Filippo Juvarra. Telluccini aveva affrontato l’incarico di seguire la dismissione delle residenze reali con un bagaglio di conoscenze derivanti dagli studi compiuti: dopo aver pubblicato già nel 1907 il testo sulla biografia di Juvarra, aveva affondato le proprie ricerche su Piffetti (1921), sulle decorazioni di Stupinigi (1924) e su L’arte dell’architetto Filippo Juvarra in Piemonte (1926), difendendo nella nota lettera inviata a Ojetti nel 1925 un’idea di museo basata su «ricostruzioni viventi di ambienti settecenteschi», con l’aggiunta di sale in cui esporre esemplari a disposizione di studiosi, amatori e fabbricanti di mobili. Alle spalle della creazione di un “Museo del Settecento” a Stupinigi agiva uno scenario che gli studi hanno ben delineato (Failla 2014): il ruolo di Lionello Venturi, gli esempi di Vienna e Berlino, le riflessioni della museologia italiana del primo dopoguerra, l’affacciarsi di nuove soluzioni ai criteri di ambientazione delle opere e la collisione con i nuovi indirizzi della storiografia artistica.
Il raggiungimento di «un ordinamento estetico, suggestivo […] in modo da riproporre un ambiente vissuto e tuttora vivente, con un grande valore educativo» fu uno degli aspetti maggiormente posti in evidenza da Lorenzo Rovere, che insieme a Telluccini avrebbe trasferito questa riuscita mediazione tra selezione e contestualizzazione degli oggetti nell’allestimento di Palazzo Madama (Rovere 1926).
Quando Viale ricevette l’incarico di dirigere il Museo Civico di Torino, le collezioni d’arte antica e di arti decorative si trovavano in una condizione di sofferenza, costrette negli spazi troppo angusti e inadeguati della sede originaria. L’assetto espositivo manteneva con una certa inerzia l’impostazione del museo di arti applicate all’industria, declinato secondo l’allestimento esemplare messo a punto da Vittorio Avondo a cavallo del 1900. Tra i primi tentativi di aggiornamento, in una delle sale Viale aveva raccolto mobili, quadri, stoffe e ceramiche del ’700, «quasi a creare, con il poco che il Museo possiede, un ambiente, che dia una pallida idea dello splendente secolo decorativo» (Viale 1931). Nel costante bilanciamento tra storia dell’arte, rispetto degli equilibri formali e criteri di ambientazione, Viale intraprendeva un percorso di raffinata revisione museografica, culminante con il trasferimento delle collezioni nelle sale di Palazzo Madama tra il 1932 e il 1934.
Palazzo Madama aveva riacquistato con il restauro degli anni Venti l’aspetto settecentesco di residenza sabauda. L’intervento sugli ambienti aveva avuto come scopo quello di ripristinare un preciso momento storico della vita del palazzo: un dettagliato riferimento documentale, ossia l’inventario dei mobili redatto nel 1724 alla morte di Maria Giovanna Battista di Savoia, aveva sostenuto filologicamente il ritorno alla facies della Madama Reale (Pagella 2006). Complice probabilmente la difficoltà a convivere, in una siffatta situazione politica, con la stratificazione risorgimentale che ancora risultava tanto evidente nel palazzo, si procedette con la cancellazione di tutti gli inserimenti ottocenteschi, compresi gli stalli che erano stati creati per accogliere il Senato subalpino e successivamente il primo Senato del Regno d’Italia.
Il raggiungimento di «un ordinamento estetico, suggestivo, il quale presenti alla massa dei visitatori […] una visione dell’arte del passato distribuita in ambienti […] in modo da riprodurre un ambiente vissuto e tuttora vivente» fu uno degli aspetti maggiormente posti in evidenza da Lorenzo Rovere, che insieme a Telluccini avrebbe trasferito questa riuscita mediazione tra selezione e contestualizzazione degli oggetti nell’allestimento di Palazzo Madama (Rovere 1926). Accanto ai lavori si provvedeva all’approvvigionamento di opere e arredi, condotto in prima battuta verificando possibili acquisizioni dalle dimore storiche e coinvolgendo antiquari e collezionisti privati. In un’ottica di sostanziale continuità, grazie anche alla presenza dell’architetto Gianni Ricci, profondo conoscitore del Settecento piemontese, Viale integrò gli ambienti con ulteriori arrivi dalle residenze, sfruttando e amplificando il potenziale offerto dalla rinnovata identità architettonica e decorativa dell’edificio.
La Mostra del Barocco piemontese si estendeva lungo tutto il primo piano di Palazzo Carignano. La scelta, che consentiva di inserire nel circuito dell’esposizione uno degli edifici in assoluto peculiari della città, con la celebre facciata ondulata disegnata da Guarino Guarini, era stata dettata anche da una ragione di opportunità: in vista del trasferimento delle collezioni del nuovo Museo del Risorgimento, previsto per l’anno successivo, tutte le sale erano state sistemate e adattate, appositamente pensate per una destinazione espositiva. Anche gli appartamenti dei Principi di Carignano, al piano terreno, erano stati oggetto di un importante restauro: grazie ai lavori compiuti, era nuovamente possibile apprezzare la struttura originaria dei saloni, la fastosità delle decorazioni a intaglio e la maestria degli stucchi, culminanti nei soffitti affrescati tra la fine del ’600 e l’inizio del ’700 da Stefano Maria Legnani (il Legnanino).
La ritrovata dimensione di residenza barocca di Palazzo Carignano s’inseriva così naturalmente nel progetto di Viale: «Compiuto il giro del primo piano, si discenderà per la bella scala elicoidale del Guarini al piano terreno, e si potrà visitare le sale del palazzo, che danno un’idea di un appartamento principesco del 600 e del 700, con lo splendore dei legni dorati e delle specchiere, con la ricchezza dei mobili, con la vivacità degli affreschi e delle pitture» (dattiloscritto s.d., AMCTo, SMO 15.1). Non a caso gli interni monumentali del palazzo furono ampiamente documentati dalla campagna fotografica commissionata da Viale in concomitanza con la preparazione della mostra e compaiono tra i soggetti maggiormente riprodotti nella serie delle cartoline promozionali.
L’archivio dei Musei Civici consente di ripercorrere con una consistente mole di documentazione la fase di concezione e organizzazione della mostra, sebbene l’assenza del catalogo sia di ostacolo per una puntuale e definitiva verifica. Le immagini a nostra disposizione riproducono solo una parte delle sale allestite e l’analisi delle diverse planimetrie appuntate da Viale nella fase di progettazione non ha fatto emergere una rappresentazione dell’assetto completo e definitivo del percorso della mostra, sebbene la pianta qui pubblicata possa essere considerata quella più vicina alla soluzione finale.
Inaugurata il 19 giugno 1937, la Mostra del Barocco piemontese si distribuiva su 47 sale, a cui se ne aggiunsero due a distanza di poche settimane (11 luglio) e altre cinque nei primi giorni di agosto, per un totale di 54 sale espositive.
L’impostazione della mostra, trasversale alle tipologie di opere e favorevole alla commistione dei generi, fondeva pittura, scultura, architettura e arti minori. I principi della complementarietà, della variazione e dell’alternanza sostennero la visione di Viale anche nella concezione dell’itinerario e nell’individuazione delle soluzioni espositive, dove si susseguivano ricostruzioni d’ambiente, ricomposizioni cronologiche e tipologiche e momenti di approfondimento monografico. La capacità di mantenere uno stile narrativo unitario era garantita dalla cifra museografica, improntata a un misurato criterio di selezione e ambientazione per gli oggetti e su cui Viale si era affidato all’architetto Augusto Cavallari Murat.
Superato il porticato monumentale sul lato ottocentesco di Palazzo Carignano, il percorso aveva inizio al primo piano. Varcato un vestibolo d’ingresso, il pubblico si affacciava su uno spazio lungo, delimitato da una cornice rettangolare, ed era colto da una vista inaspettata, una sorta di diorama in dimensioni naturali che riproduceva l’approdo della Peota su un tratto di spiaggia del fiume Po. Il potere evocativo di questo primo ambiente della mostra, giocato su un coinvolgimento misurato e contemplativo, esprime l’impronta stilistica con cui Cavallari Murat aveva affrontato le scelte di allestimento.
La Peota di Carlo Emanuele III, realizzata a Venezia nel 1730 e giunta a Torino per via fluviale, era tra le opere più sorprendenti del Museo d’Arte Antica: esposta all’interno di un padiglione appositamente costruito presso la sede di via Gaudenzio Ferrari come raro esempio di perizia scultorea, questa sontuosa imbarcazione intagliata e dorata era destinata a colpire l’immaginario non solo degli amanti dell’arte. L’opportunità di esporla al di fuori dello spazio museale, all’interno di un contesto che potesse valorizzare la sua particolare unicità, era stata presa in considerazione già nel 1929, quando ne fu richiesta la disponibilità per la Mostra Il Settecento italiano (Rovere 1929). Le difficoltà tecniche e i rischi connessi con l’eventuale trasporto ne sconsigliarono il prestito a Venezia; per il 1937 si rese necessaria una complessa movimentazione, documentata da immagini e filmati dell’epoca che contribuirono ad alimentare l’attesa e la curiosità del pubblico in vista dell’inaugurazione.
L’idea di preparare il visitatore alla comprensione del contesto storico e sociale in cui si collocava la produzione artistica era presente fin dai primi appunti con cui Viale fissava il progetto espositivo: «con un concetto forse nuovo per una mostra, la rassegna delle espressioni artistiche sarà preceduta da sintetiche visioni, che a grandi linee inquadreranno nella mente del visitatore, accanto alle maggiori e più rappresentative figure dei nostri principi, gli eventi più notevoli della storia sabauda e piemontese del tempo […]» (dattiloscritto s.d., AMCTo, SMO 15.1). Tre furono le sale storiche introduttive: la “Sala delle glorie militari del Piemonte”, la “Sala dei Monarchi” e la “Sala delle attività produttive”. Viale e Cavallari Murat avevano già avuto modo di sperimentare alcune soluzioni per rappresentare i fatti storici: il loro primo incontro era avvenuto, entrambi curatori, in occasione della Mostra storica. Celebrazioni di grandi piemontesi che si era tenuta nell’autunno del 1935 nelle stesse sale di Palazzo Carignano. L’esito felice di queste “prove museali” avrebbe avuto fortuna anche in seguito, sia nella mostra Gotico e Rinascimento del 1938, sia in quella dedicata a Vercelli e la sua provincia dalla romanità al fascismo inaugurata nel 1939 come primo assetto del rinnovato Museo Leone.
Di queste esperienze scrisse direttamente Cavallari Murat, ricordando la necessità di adottare un registro differenziato all’interno della mostra, per «trattare in appropriati modi diseguali da una parte oggetti d’arte figurativa e dall’altra atmosfere ambientali idonee alla comprensione dei cimeli storici e di costume […]. L’idea di vetrine con luce naturale di striscio dai lati era stata tentata anche nella mostra del barocco piemontese, collocandole nelle sale dotate di due finestre: ne ricordo una particolarmente ammirata accogliente fusti di cannone e bandiere tenute spiegate come portate in battaglia e garrendo nel vento. Il motivo di oggetti da vedersi al di là di un telaio, illuminati lateralmente, lo sperimentai, sempre nella mostra del barocco piemontese, dando luogo in planimetria ad uno spazio architettonico illuminatissimo separato da un accesso anteriore mediante una specie di vetrata o cancello che disegnai in modo che le statue di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III fossero legati dal blasone sabaudo» (Cavallari Murat 1982).
«[Dopo] l’acclimatazione culturale e storica si disponevano le collezioni artistiche con criteri di rigore museale, servendo discretamente gli oggetti con calde e misurate intonazioni di contorno atte a facilitare solamente la degustazione estetica» (Cavallari Murat 1982). Il discorso figurativo prendeva avvio con le sale dedicate alla pittura e alla scultura del Seicento: la documentazione fotografica ci restituisce uno di questi ambienti, dove si riconoscono i dipinti di Dauphin e Giovanni Battista Della Rovere sulla parete sinistra, di fronte ai busti di Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista nelle vesti di Apollo e Diana provenienti dal Castello di Rivoli (e cautamente riferiti al luganese Bernardo Falconi). Sulla parete frontale, chiusa dalle due vedute del Garola, l’alcova in legno intagliato e dorato prestata dal pittore e senatore Giacomo Grosso, acquisita dai Musei Civici l’anno successivo.
Il migliore viatico per la comprensione delle scelte operate sulla pittura è rappresentato dal saggio pubblicato da Viale in più puntate nel 1942 dedicato alla Pittura del Settecento in Piemonte. Il testo si apriva, significativamente, con la citazione de Il pregiudizio smascherato di Ignazio Nepote, un poemetto del 1770 che sfidava l’opinione diffusa secondo cui Torino non meritasse di comparire tra i grandi centri italiani della produzione artistica. Viale attribuiva questa fragilità alla mancanza di studi dedicati alla pittura in Piemonte nell’età barocca e ne sottolineava conseguenze ancora molto influenti sulle fortune della città, non ultima la difficoltà di “attirare visitatori, estimatori e studiosi” (Viale 1942a, b, c).
Dovendo fare i conti con un panorama prevalentemente occupato dalla presenza di pittori stranieri attivi per il ducato, Viale inquadrava la pittura secentesca come «utile premessa» al secolo successivo: ritenendo più convincenti le fila dei pittori “oltramontani” come Dauphin e Miel, oppure Daniel Seiter in un secondo momento, non riconosceva particolari virtù alla scuola locale (che negli elenchi di preparazione della mostra comprendono Nicola Musso, Antonio Molineri, Tanzio da Varallo, Pietro e Lorenzo Dufour e Bartolomeo Caravoglia).
Varcando l’arcone di alcova il percorso espositivo cambiava registro e introduceva il visitatore all’interno di una camera da letto, dove le nature morte di Montfort, la madia dipinta a fiorami, la culla e l’inginocchiatoio (tutti provenienti da collezioni private) erano scandite dalle vivaci lesene ricamate e dipinte provenienti dalla chiesa delle suore carmelitane di San Giuseppe a Moncalieri, un’intuizione di notevole impatto visivo che ritornerà (ma con più robuste acquisizioni) nella mostra del 1963.
La produzione scultorea del Seicento e del Settecento, di prevalente provenienza ecclesiastica, occupava una nutrita successione di sale. Superato un piccolo ambiente, dove erano esposti alcuni arredi di Pietro Botto provenienti da Volpiano, si entrava nell’atmosfera un po’ sospesa e rarefatta della cosiddetta “Sala dei bronzi”, dove l’Angelo portatorcia di Ladatte della chiesa del Carmine, la statua in bronzo del Beretta, il cancello in bronzo proveniente dal novarese e il San Michele Arcangelo del Carlone (riconoscibile in una fotografia d’epoca che documenta la visita del Principe Umberto) erano oggetto di un allestimento in chiave estetizzante, destinato a enfatizzare il pregio della selezione.
La presentazione degli arredi e della scultura sacra, come mostrano le immagini, coniugava momenti di coerenza stilistica o geografica con aggregazioni di carattere tipologico. Nella sala 11, per esempio, dove erano esposti altari, mobili, arredi e dipinti del Seicento, i grandi leggii provenienti dalla chiesa di San Secondo di Asti (sulla sinistra) e dal duomo di Chieri (sulla destra), insieme all’imponente altare di Masserano, erano stati accostati alla tela di Dauphin proveniente dalla chiesa di San Francesco da Paola di Torino e alle due grandi tele di Giovanni Antonio Mari giunte anch’esse dal duomo di Chieri. La sala 14, anch’essa dedicata agli arredi sacri e ugualmente dominata dalla presenza di un altare monumentale (quello dell’oratorio di San Pietro Apostolo a Casale Monferrato, ripreso durante le fasi di montaggio dalle cineprese dell’Istituto Luce), sembra organizzata maggiormente secondo un accostamento su base tipologica, non distante probabilmente dalla consuetudine con le arti decorative che Viale esercitava all’interno del Museo Civico d’Arte Antica.
Accanto alla scultura l’itinerario di visita inseriva una sosta in due piccole sale, una riservata alle argenterie sacre, «la vera rivelazione della mostra», come segnalava Viale nei suoi appunti (dattiloscritto s.d., AMCTo, SMO 15.1), e l’altra alle ceramiche, ambito su cui il direttore aveva maturato un’ampia esperienza durante l’allestimento del secondo piano di Palazzo Madama.
L’affluenza di esemplari di pregio provenienti dal territorio piemontese, spesso poco conosciuti, doveva molto alla capacità di intrattenere un dialogo costante con gli studiosi e gli interlocutori locali, non ultimi gli esponenti del clero. Il comitato esecutivo della mostra, di cui facevano parte i due soprintendenti Carlo Aru e Vittorio Mesturino e l’architetto Arturo Midana, includeva anche il conte Carlo Lovera di Castiglione, delegato dall’arcivescovo Maurilio Fossati e che nel 1931, proprio con Vittorio Viale, aveva organizzato la mostra storica retrospettiva a Palazzo Madama in occasione dell’ostensione della Sindone.
Conclusa la sezione sulla scultura e gli arredi sacri, il percorso di visita tornava ad essere immersivo, con la riproposizione degli arredi appartenenti all’antica farmacia dell’ospedale di San Giovanni, smontati dalla loro sede originale e ricostruiti in mostra. L’ambiente, straordinariamente conservato con i suoi mobili e le suppellettili originali, era noto agli specialisti anche grazie alla segnalazione di Midana nel volume del 1926.
Lo spazio della farmacia invitava a una sorta di pausa all’interno del percorso espositivo, utile anche per predisporre il visitatore all’ingresso nella sezione successiva che rappresentava il cuore concettuale della mostra: la sezione dedicata all’architettura.
La prima sala, sull’architettura del Seicento (Guarini, Vitozzi, Lanfranchi e i Castellamonte), ci è giunta attraverso uno schizzo progettuale di Viale, in cui si osserva l’ipotesi di organizzazione dello spazio da un punto di vista fisico e mentale, in particolare per quanto riguarda la parte riservata a Guarini: i suoi disegni, le fotografie e gli altri materiali utilizzati per raccontare il suo lavoro sono scanditi da una successione logica molto chiara e narrativa (“come nasce l’idea” – “razionalità costruttiva ed essenzialità” – “architetture civili” – “sviluppi barocchi in Germania e Austria”). La selezione di opere si basava in particolare sull’esposizione di disegni, ma si avvalse anche di vedute, modelli e riproduzioni fotografiche, una soluzione espositiva che Viale aveva felicemente sperimentato nelle mostre storiche e che avrebbe perfezionato ancora successivamente, a partire da Gotico e Rinascimento nel 1938.
La sezione su Filippo Juvarra era sostenuta da una rassegna di materiali originali di elevata qualità, con i disegni per il progetto di San Filippo Neri e del Castello di Rivoli ottenuti dalla Biblioteca Nazionale di Berlino (grazie alla mediazione di Brinckmann) e la sala con gli undici volumi di disegni autografi, datati dal 1706 al 1735, provenienti in parte dalle collezioni del Museo Civico di Torino.
All’esatta metà del percorso di visita si situavano le due sale destinate a imprimersi nel ricordo dei visitatori, come dimostrano le numerose recensioni: la prima, di forma circolare, rendeva omaggio al tema della scenografia, con la riproduzione di suggestivi teatrini in piccola scala realizzati dal professor Renato Testi del Teatro Regio; la seconda era la “Galleria dei Paramenti e delle Stoffe”, descritta da Marziano Bernardi come «un insieme smagliante di trapunti d’oro e d’argento, di deliziosi colori, d’accordi cromatici raffinatissimi» (Bernardi, in «La Stampa», 21 maggio 1937).
Nella sala successiva, in un clima di rarefatta selezione, la cancellata del Sacro Monte d’Orta era attorniata dalle sculture di Stefano Maria Clemente provenienti da Collegno (Parrocchia di San Massimo). L’immagine cattura sullo sfondo uno scorcio della “Cappella”, dove era collocata la sopracaminiera in legno di noce con la veduta in prospettiva della Battaglia di Guastalla, di proprietà dei Musei Civici ma proveniente dal Castello del Valentino.
S’inseriva a questo punto un nuovo momento di apertura al tema della pittura: la scelta di dedicare una saletta monografica a Pier Francesco Guala rendeva merito agli studi condotti da Noemi Gabrielli, che era giunta a definirlo quale «gloria del Monferrato e della pittura italiana» (Gabrielli 1935). La selezione delle opere aveva consentito di sottrarre all’abbandono e alla trascuratezza i 12 dipinti provenienti da Casale, rinvenuti in pessimo stato di conservazione e sottoposti a restauro. A differenza di quanto osservato a proposito del ’600, dove faticava a individuare degli snodi significativi, per il ’700 Viale poteva muoversi più agevolmente verso il riconoscimento di una stagione pittorica più propriamente piemontese, con una progressiva riduzione della componente “straniera” destinata a risultare senz’altro più accettabile nel clima politico del tempo.
Superato un ambiente riservato alle legature, provenienti in gran parte dalla Collezione Simeom, che in anni successivi sarebbe stata acquisita come base per un costituendo Museo di Storia della Città, la mostra assegnava a Pietro Piffetti uno degli affondi monografici, riunendo alcuni degli arredi più rappresentativi della sua produzione, dalle opere di pertinenza ecclesiastica agli arredi per le residenze. La scrivania giunta in prestito dal Museo Correr rammentava la sala a lui dedicata nella mostra veneziana del 1929. Ebanista regio e raffinato interprete del disegno juvarriano, Piffetti era stato tra gli artisti settecenteschi più precocemente studiati, fin dalla Mostra dell’Arte Antica del 1880, dove comparivano una ventina di suoi esemplari. Nel catalogo del 1963, trattando direttamente il tema degli arredi lignei, Viale dedicherà all’autore un capitolo a parte.
Vittorio Amedeo Cignaroli, protagonista della sala successiva, fu tra gli artisti maggiormente rivalutati in seguito alla mostra, grazie anche all’ingente quantità di dipinti giunti per il tramite dell’antiquario Pietro Accorsi, che aveva messo a disposizione di Viale la fitta rete di contatti con un collezionismo locale e nazionale. Il riconoscimento storico critico della produzione artistica tra ’600 e ’700, a cui le rassegne espositive fornivano inevitabilmente una cassa di risonanza, ebbe prevedibili ripercussioni sul mercato antiquariale. Ne è un esempio il lambriggio «completo di riquadri e di ventidue pannelli ad olio (23x21) dipinti dal Cignaroli», proveniente dalla residenza di Federico Ricardi di Netro, smontato in occasione della mostra e successivamente venduto con la mediazione di Accorsi.
Preceduti da una rassegna di mobili e pittura di genere del Settecento e da un cospicua raccolta di argenterie ebraiche (provenienti dalla collezione romana di Michele Segre), con la “Sala di palazzo torinese con ornati in legno scolpito e dorato” entravano in scena gli arazzi della Reale Fabbrica di Torino, anch’essi selezionati come soggetti delle cartoline promozionali.
Prendeva quindi avvio una successione di ricostruzioni d’ambiente che, pur rifacendosi a soluzioni museografiche già ampiamente utilizzate, erano il sintomo di una certa disponibilità. La smobilitazione di interi apparati d’arredo e decorativi d’epoca da edifici storici fu infatti una prassi diffusa tra gli anni ’20 e ’30, quando il centro cittadino fu oggetto di una radicale trasformazione architettonica e urbanistica: oltre ad alimentare un fitto mercato antiquariale, questa pratica contribuì ad addestrare architetti e maestranze nel riprodurre tecniche e forme originali. Questa agilità dovette favorire indubbiamente anche Vittorio Viale, che nelle poche settimane a disposizione per la preparazione della mostra dovette affrontare consistenti lavori di rimontaggio e allestimento.
Tra gli ambienti riproposti in Palazzo Carignano figuravano la “Camera di San Remo”, fermata da Accorsi sulla via dell’esportazione e fatta trasferire a Torino appositamente per la mostra, e la “Camera da letto Abegg”, che con la sua tappezzeria in broccato e le porte in legno scolpito, accostate a prestigiosi pezzi di ebanisteria e scultura piemontese, illustrava perfettamente un interno privato di secondo Settecento.
Il collezionista Werner Abegg sosteneva da tempo le strategie di acquisizione del Museo Civico d’Arte Antica: nel 1930 il dono da parte sua di una stanza valtellinese era stato accolto da Viale come «l’inizio di un futuro programma, la formazione cioè nel museo di una serie di ambienti che rendano ad evidenza al pubblico la storia degli stili dal ’400 all’800» (Viale 1931). Il concetto che il museo potesse offrire una serie di ambientazioni in cui favorire la trasmissione dei contenuti al visitatore, anche grazie a una componente di intrattenimento, e più in generale l’equilibrio tra la vocazione didattica e la ricerca di una dimensione estetica distintiva per il museo contemporaneo furono i principali argomenti affrontati dalla Conferenza internazionale di museografia di Madrid del 1934 (Kannes 2011; Cecchini 2013). A questo dibattito Viale partecipava con gli esiti recenti dei suoi interventi sulle collezioni civiche (Museo d’arte antica e Galleria d’arte moderna) ma anche con un interesse particolare verso i musei di storia della città europei e americani, noti per le loro ricostruzioni e per alcune forme di spettacolarizzazione del passato: da modelli di questo tipo maturò infatti l’ideazione del “Museo di Torino”, un progetto promosso a più riprese ma che non fu mai possibile portare a compimento (Abram 2004).
L’inserimento di una parte degli appartamenti aulici di Palazzo Carignano all’interno del percorso consentiva a Viale di richiamare in mostra gli ambienti e il cerimoniale di corte, accogliendo al contempo una delle migliori espressioni della cultura figurativa a ridosso del 1700 presente in quel momento a Torino (il soffitto dipinto da Legnanino).
Gli arazzi della Regia Fabbrica di Torino su disegno di Beaumont (Storie di Alessandro, provenienti da Palazzo Reale), insieme alla balaustra di metà ’700 del Palazzo Reale di Genova, erano stati accostati già nel 1929 all’interno della sala denominata “Aula dei Savoia”, una delle prime nell’itinerario espositivo e tra le più apprezzate di tutta la mostra. Il Barocco piemontese aveva marcato il panorama presentato a Venezia offrendosi come espressione del potere e del gusto dinastico, con dipinti, bassorilievi e sculture raffiguranti la ritrattistica sabauda e un assaggio dell’arredo di corte grazie ai sedili con dossali provenienti da Palazzo Madama.
A Torino nel 1937 il punto di partenza di Viale continuava ad essere quello delle scelte della casa reale, per poi esplorare la fortuna di modelli, tendenze e maestranze nelle numerose varianti presenti all’interno delle residenze nobiliari, spesso ancora disponibili nella loro integrità storica e stilistica. Una delle tappe di Palazzo Carignano restituiva per esempio l’immagine del salotto aristocratico, tramite gli arredi dei conti Rasini giunti grazie ad Accorsi; altrove si richiamava l’apprezzamento per l’esotismo tipico del Settecento con i pannelli del salotto cinese di proprietà Medici del Vascello, uniti allo stipo su tavolo proveniente (non a caso) da Villa della Regina.
Per quanto riguarda il trattamento e la sensibilità nei confronti delle ambientazioni e degli arredi di gusto orientale, Viale aveva potuto meditare anche sulle scelte compiute da Telluccini per il Gabinetto cinese di Palazzo Madama: in quel caso, sempre sulla base delle indicazioni fornite dall’inventario storico, la conservazione delle decorazioni settecentesche si era sposata con l’inserimento di una nuova tappezzeria in seta e l’aggiunta di sovrapporte in carta dipinta provenienti dalla Villa Moglia di Chieri, nella commistione tra parti originali, rifacimenti in stile e integrazioni con materiali d’epoca a cui si era fatto ricorso per la restituzione del piano nobile (Pagella 2006).
La sala con il refettorio proveniente dal Santuario di Vicoforte presso Mondovì apriva un punto di osservazione sulle testimonianze artistiche disseminate nei territori delle province piemontesi. Pubblicati prima da Midana e successivamente dallo stesso Viale nella loro collocazione originale, dove si apprezza la complementarietà con le decorazioni murali e con l’affresco della Cena in Emmaus, i sedili del refettorio si offrivano qui nelle loro qualità tecniche e tipologiche, senza alcuna concessione a un’eventuale ipotesi di restituzione del contesto di provenienza: alle pareti della sala s’individuano la tela di Dauphin da San Francesco da Paola, l’Adorazione dei Pastori di Metey proveniente dai Padri Somaschi di Cherasco e i due Angeli di Cantalupi della parrocchiale di Masino.
L’itinerario proseguiva quindi nuovamente con l’ultimo ambiente arredato presente in mostra, dove erano esposti i pannelli dipinti prelevati dal Salotto di Villa Palma Nola di Orbassano, intercettati anche in questo caso grazie alla segnalazione di Midana, che della stessa residenza privata aveva inoltre pubblicato la Galleria e la Camera da letto.
Nell’ormai consueta alternanza di proposte espositive differenti, destinate a rendere più interessante la visita alla mostra anche per un pubblico non specialistico, si tornava dunque a una sala monografica. Come sostenuto per l’architettura, fu «l’influenza rinnovatrice del Juvarra» ad aver agito da innesco per «il felice svolgimento della pittura piemontese del settecento», grazie al coinvolgimento dei migliori artisti dell’epoca nelle imprese decorative della capitale e con l’invio dei giovani pittori piemontesi presso le principali scuole italiane (Viale 1942a, b, c). La figura più adatta a testimoniare questa visione era senz’altro quella di Claudio Francesco Beaumont, divenuto pittore di corte nel 1731 (dopo ripetuti e prolungati soggiorni romani) e successivamente primo direttore della scuola del disegno di Torino.
Con le due nuove sale aperte nel mese di luglio e altre cinque a inizio agosto, l’itinerario di visita si completava con incisioni e disegni originali di Guala, Olivero e Beaumont, un album di scenografie di Fabrizio Galliari, disegni per argenterie di Giovan Battista Boucheron, piante topografiche, vedute, volumi illustrati e guide della città.
Prorogata di oltre un mese rispetto a quanto inizialmente previsto, la mostra si sarebbe chiusa il 5 dicembre dello stesso anno: gli orari ampi di apertura (tutti i giorni mattina e pomeriggio, il sabato e la domenica con orario continuato e la sezione di Palazzo Carignano visitabile anche la sera dalle 21 alle 23), le convenzioni con enti e società di trasporto e la considerevole esposizione mediatica ne decretarono un importante successo di pubblico, arrivando a contare oltre 200.000 visitatori.
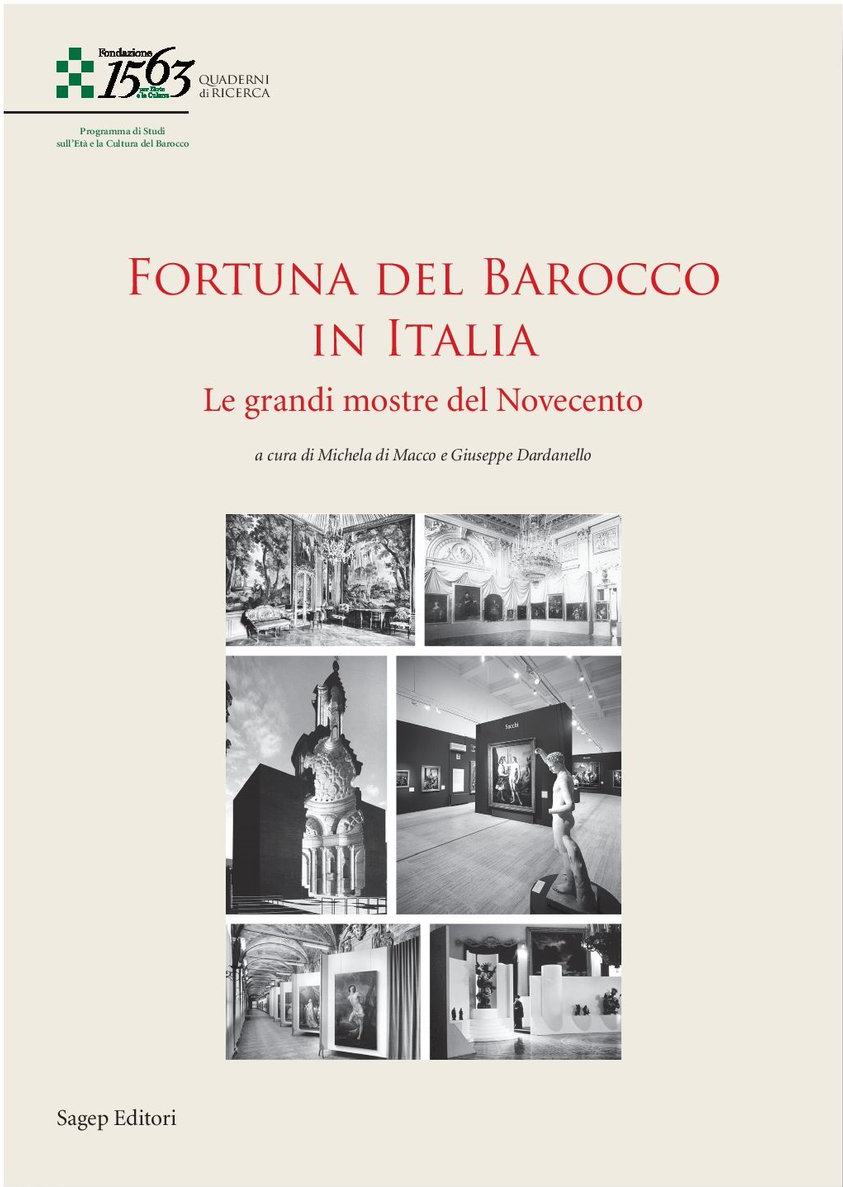

1937 - Mostra del Barocco Piemontese
Contatti
- Piazza Gian Lorenzo Bernini, 5, 10138 Torino
-
Tel. +39 011 4401401
Fax + 39 011 4401450 - info@fondazione1563.it


